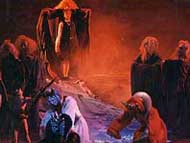Appunti
di regia per l'edizione 1979
a)
E L A B O R A Z I O N E __D
E L__ T E S T O
 L'INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DEL
CONTRASTO LINGUISTICO
L'INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DEL
CONTRASTO LINGUISTICO
È
dalla contrapposizione linguistica tra il verso nobile dei re e la
prosa volgare dei comici adottata dall'originale shakespeariano che
parte dall'idea-base della riduzione.Il ricorso non al dialetto napoletano
bensì alla "parlata partenopea" non è quindi
occasionale ne pretestuoso e la sua utilizzazione, in luogo della
prosa "villana", così come la utilizzazione della
lingua italiana in luogo del verso colto, mi è parsa necessaria
addirittura per la più corretta interpretazione del contrappunto
linguistico dell'originale.
 LA INDIVIDUAZIONE DELLA CIRCOLARITA' DEL TESTO
LA INDIVIDUAZIONE DELLA CIRCOLARITA' DEL TESTO
Il
"Sogno" è un cerchio perfetto, mentre all'apparenza
può sembrare un fascio di rette parallele. Nella riduzione
ho cercato ancor più di rendere evidente questa circolarità
che è nella tecnica drammaturgica di Shake speare.
Es. : Un prologo senza musica
e una musica senza fine
- da una notte fino ad un giorno
e da un giorno fino ad una nuova notte-
"Ogni tragedia finisce in commedia" e
"Ogni commedia finisce in tragedia"-
Le corse degli innamorati
le ricorse all'incontrario.
 L'AMPLIAMENTO
FINO ALL'ESTREMO LIMITE
L'AMPLIAMENTO
FINO ALL'ESTREMO LIMITE
della
tecnica della convergenza e dell'incastro tra le trame.
 LA
CRITICA ALLA NAPOLETANITA'
LA
CRITICA ALLA NAPOLETANITA'
e
all'uomo napoletano, dilettante nella vita oltre che sulla scena,
"nciarmone" oltre che per ignoranza e miseria anche e soprattutto
per superficialità.
 LA
PREVALENZA DEL LUOGO REALE DEL BOSCO
LA
PREVALENZA DEL LUOGO REALE DEL BOSCO
nel
quale è ambientata l'intera commedia al di là di quanto
è nel testo originale, ad esclusione della prima parte che
qui funge da prologo.
b)
L A __R E G I
A __E __L
A __M E S S I N S C E N A
Alcuni punti:
- Ruolo dell'attore e sua libertà creativa.
- La commedia dell'Arte e Shakespeare. Rapporti.
- Necessità del luogo-BOSCO REALE,perché il Sogno nasce
per l'erba ed è compiuto solo sull'erba.
- I PIANI: il reale, il fantastico, il simbolico.
- Come corrispondenti ad essi, da un punto di vista formale: il leggermente
decò della nazione reale, il visionario di Bosch per il fantastico
bestiale del bosco, l'astratto per il simbolo e l'onirico.
- Le musiche: deliberatamente non più romantiche, ma di contrasto.
Ammiccanti a un'epoca per il reale, indefinite per il fantastico ed
il simbolo.
- IL SOGNO come: incubo della perdita della libertà, come:
Commedia del Destino e non dell'Amore, come: Commedia dell'Erotismo,
come tragedia della napoletanità, come: favola.
b) I PERSONAGGI
La Nazione immaginaria mortificata dalla testardaggine di un padre non
ottuso, ma incestuoso.
Il bosco con gli Dei-Evento e non persona: elementi della natura, mimetici
e camaleontici.
Oberon a Titania, ovvero della sessualità inconscia e inconsapevole:
rapporto Titania-Zeppola come rapporto donna-bestia, poesia-prosa, intelligenza-stupidità.
Puck, demone multiplo e moltiplicabile, genio della velocità,
fauno e arlecchino, non Ariele, quindi, e non donna per conseguenza.
Gli innamorati come persone e non stereotipi intercambiabili.
I napoletani come condizione, e non come clowns: Tragici e non comici.
Il Destino, come personaggio aggiunto, vero protagonista del SOGNO.
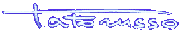
|
|
Il
"Sogno" di Tato Russo
Domenico Rea- Il Mattino 1979
Il
"Sogno" di Shakespeare può prestarsi e diventare qualsiasi
cosa.
Può devitalizzarsi, sconfinando sui prati esangui dell'Arcadia
e
coagularsi in un mare indistinto di parole sospirose e può degenerare,
dopo la lezione critica fornitaci da Jan Kott, in serraglio ed in orgia.
Tato Russo ha prestato orecchio a tutti, ma poi ha scelto la via di
mezzo.
Ha lasciato che il "il sogno" rimanesse un sogno ( e vi ha
introdotto le musiche romantiche di Mendelssohn e di Grieg ) ma, come
un dirigibile attaccato ai piloni, non l'ha mai sganciato del tutto
dalla terra.
Ha cercato di riempire quel gioco di ombre di cui l'opera di Shakespeare
trabocca, storicizzandole; per cui, per fare un esempio, Elena la solita
innamorata respinta, e dedita al lamento delle sue pene, diventa una
creatura attendibile con la sua recita-ribellione, condotta con isterismo.
La storicizzazione, o il rapporto con la realtà, diventa predominante
quando Tato Russo sospinge nel quotidiano napoletano e nella sua aspra
dialettalità la troupe di quei poveri artigiani stracciati che,
per tirare a campare, s'improvvisano attori e concorrono al premio teatrale
bandito dalla corte in occasione delle nozze di Teseo ed Ippolita. Come
tutti sanno, nel "Sogno di una notte di mezza estate", i personaggi
regali ed aristocratici si esprimono in versi; i poveri diavoli in prosa,
in uno "slang" pesante e becero.
Tato Russo ha intuito subito questo contrasto, spostandolo su un piano
realistico; i ricchi e i poveri; il potere e la sudditanza e, qui giunto,
si trattava di dare soltanto un altro piccolo passo per individuare
in quei sudditi la plebe. E quale plebe? Quella napoletana. Ora, quei
poveri artigiani che cercano d'improvvisarsi attori per risolvere il
problema di una fame congenita che sta loro addosso come la pelle, nel
"Sogno" visto da Tato Russo, si introducono come dei Pulcinella
spinti al massimo del viscerale, provocando una resa terrestre che rende
il "Sogno" scespiriano ancor più sogno. Mentre il gruppo
aristocratico si smarrisce dietro i giochi del cuore, sbattuti qua e
là dal destino che li unisce, li separa e li riunisce, gli artigiani-attori
cercano di aggrapparsi alla realtà per un meritato riposo a pancia
piena. Quello che in Shakespeare è soltanto uno spunto, la possibile
recita di Piramo e Tisbe, condotta da un gruppo di dilettanti analfabeti,
destinato ad una funzione comica, nella riduzione di Tato Russo si dilata
ad uno spazio immenso e costituisce una sorta di commento rovesciato
di un altro "Sogno": quello del digiuno, ossia dei napoletani
in cerca sempre di qualcosa che non trovano e non troveranno mai fino
a quando non si daranno ragione del loro autolesionismo masochistico.
Non si poteva sorvolare su questo versante del "Sogno" di
Tato Russo perché metà dello spettacolo ne è pieno.
L'idea della riduzione è proprio in questa contrapposizione tra
il mondo fantastico e quello visionario e per converso tra questi due
e quello della realtà. Dice il regista: "è solo alla
perfetta equidistanza di questi che si completa il SOGNO. Nelle precedenti
edizioni, la parte immaginario ha preso il sopravvento su quella più
radicata nella quotidianeità. Il SOGNO è compiuto, invece,
solo nella perfetta equidistanza tra i due mondi, solo nell'eguaglianza
dei loro valori e nello strepito del contrasto più totale. Questo
si è ottenuto portando alle estreme conseguenze quel valore di
contrasto linguistico già preesistente nell'opera di Shakespeare,
che, usato all'eccesso, attraverso la contaminazione dialettale, rende
perfettamente la duplicità dell'opera."
A parte il genuino divertimento fornito dalla troupe di vagabondi, i
veri protagonisti del "Sogno di una notte di mezza estate"
sono Oberon e Puck.
Oberon è un mago divertente, ambiguo ed equivoco. Gli piacciono
anche i ragazzi e per il possesso di un paggio, di cui è innamorata
la moglie Titania, cosparge i suoi filtri, provocatori di folli amori,
e scatena nel suo regno notturno quei fili sottilissimi e durissimi
dei destini incrociatiche sono poi le proiezioni dirette del subconscio.
Al suo servizio c'è Puck, il padre di Ariele (de "La Tempesta").
In Ariele si può supporre anche un'anima, una comprensione filosofica
del dramma di Prospero, suo padrone. In Puck c'è una corrispondenza
diretta con la magia istintuale di Oberon.
Se può, in autonomia, Puck si spinge anche oltre perché
ha un gusto personale ad imbrogliare le carte del cuore dei mortali.
È il suo spasso.
Oberon e Puck fanno da "pendant" alla troupe di vagabondi,
in un'altra sfera, in un'altra miseria, quella delle passioni che, come
la fame, riducono gli uomini a una metodica follia. Io non ho assistito
ad altre rappresentazioni del "Sogno di una notte di mezza estate".
Ma l'Oberon ed il Puck visti dall'altra sera sono straordinari. Quando
essi entrano in scena il "Sogno" cresce, acquista una dimensione
impalpabile da un gran fondo notturno, si sposta subito nel regno magico
indicato dal grande inglese. Oberon ha quella terribilità minacciosa
e fasulla pari alla sua ingombranza. Puck ha la morbidità, la
mobilità, la voce vegetale e l'imprendibilità, con la
sua coda luminosa a fanalino, di un folletto che tutti abbiamo potuto
intravedere in un bosco. Sono essi che commuovono i sensi delle creature
sperdute nel buio: i sensi, si badi, non i cuori, che ne restano fuori.
Tato Russo, memore della lezione kottiana, ha messo in rilievo il possibile
sottinteso erotico (e quasi di lussuria) contenuto nel "Sogno".
Fare innamorare Titania, stregata da Oberon perché gli lasci
il tenero paggio, di un asino, ossia dell'animale fallicamente meglio
fornito della natura, è quanto dire. Spingere gli amanti nel
bosco, nella foresta, ossia nel migliore dei nascondigliper consumare
i giochi d'amore al contatto con la natura, è un'altra possibile
spia erotica. Senza dire di quel paggio agognato, che non si vede mai,
causa di tutto, all'opposto della massiccia persona di Oberon, bacato
da una voglia irrefrenabile e proibita. Temi più che ampiamente
sviluppati da Tato Russo e lanciati sul prato della Pignatelli, sottoposto
a continue sorprese da "Mille e una notte". Lenzuoli volanti
di seta, cuscini di raso, cortei nunziali, luci, ad esplodere ed a spegnersi,
come fuochi artificiali, nebbie odorose di resina, il carretto dei girovaghi
e quel Mortarella, un autentico lazzaro napoletano, segnano in maniera
positiva quesst'interpretazione. Applausi infiniti durante e alla fine
della rappresentazione.
|
|
Appunti
di regia per l'edizione 1993
Queste
le indicazioni e i bei risultati di un mio primo approdo al "Sogno"
di Shakespeare 14 anni fa.
Cosa verrà fuori dopo 14 anni? Spero gli stessi risultati, anche
se le indicazioni critiche e gli spunti che mi muovono sono assai diversi.
Oggi mi pare di leggervi un mondo tutto diverso.
Che il punto di partenza non sia più in quel personaggio tutto-Bosch
del destinoche ci conduceva in un sognato tutto fantastico dove le azioni
avevano valenze tutte realistiche, così come reale era il bosco
all'aperto nel quale si svolgevano le rappresentazioni, ora a villa
Pignatelli a Napoli, ora a Villa Panphili a Roma.
La vera tragica coppia del Sogno mi paiono oggi Ippolita e Teseo, non
gli innamorati, non Oberon, non Titania, bensì solo la donna
mascolina e maschilista per eccellenza, la regina delle amazzoni, e
il maschio che più maschio ed eroico non si può, l'eroe
del Minotauro, di quel Teseo al quale ogni impresa è possibile.
Quale impresa, questa volta? Forse quella di liberare Ippolita dall'incubo
della sua verginità.
E allora forse il Sogno che parte da questi motivi di eccellenza diventerà
l'incubo dell'avventura visionaria del sesso, con l'atto sessuale qui
immaginato come violazione, violenza fisica, stupro ed inevitabile prova
di bestialità.
E quindi ci inerpicheremo lungo i sentieri della paura infantile e verginale
del sesso, dove la farà da padrone il mondo non più di
Bosch, bensì di Ginger, per rendere questo sogno di oggi come
un'immersione nel mondo fantastico dell'eros e delle immaginazioni sollecitate
da una libido troppo repressa.
E Ippolita diventata Titania sarà protagonista delle sue notti
affannose, sempre rincorsa da un Teseo eroico sverginatore diventato
ora Oberon ora Bottom, sempre comunque soggetto dello scatenamento delle
sue torbide fantasie. Ma ecco un altro spunto fascinoso della messinscena:
alla Ippolita che convola anziana o addirittura vecchio al suo matrimonio,
è contrapposta la storia di altri matrimoni giovani e resi impossibili.
Di qui la rappresentazione di un contrasto: da una parte il mondo dei
vecchi, dove il sesso è lascivia, perversione, brutalità,
vizio e malizia, dall'altra quello dei giovani, dove il sesso è
curiosità, sentimento, trasporto infinito, semplicità
di realizzazioni.
E forse da qui una serie di punti di vista o di immaginazioni: con un
bosco disegnato come il mondo del turpe e della vecchiezza, fatto d
elfi cadenti e barbosi, fate che sono arpie, re e regine di età
inestimabile, maliziosi puck tutti a disputare e a rincorrere giovanili
schiavetti o a disturbare i sogni infantili dei quattro giovanetti innamorati.
E così questo spostamento dal bosco reale della prima edizione
e questo bosco irreale, luogo della mente, ci porterà in una
lunga "notte di San Giovanni", notte di sesso e di perdizione
dove appunto "perdersi", "mutarsi", "travestirsi",
"scambiarsi", quasi maschere d'un carnevale della fantasia,
sarà il punti d'incontro di tutti i personaggi.
Un viaggio anche nella memoria dei segni della nostra infanzia tornata
alla mente con le sue incredibili amplificazioni e commista a quel mondo
delle tradizioni popolari che è il vero sottosuolo dal quale
muove ognuno di noi.
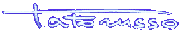
|